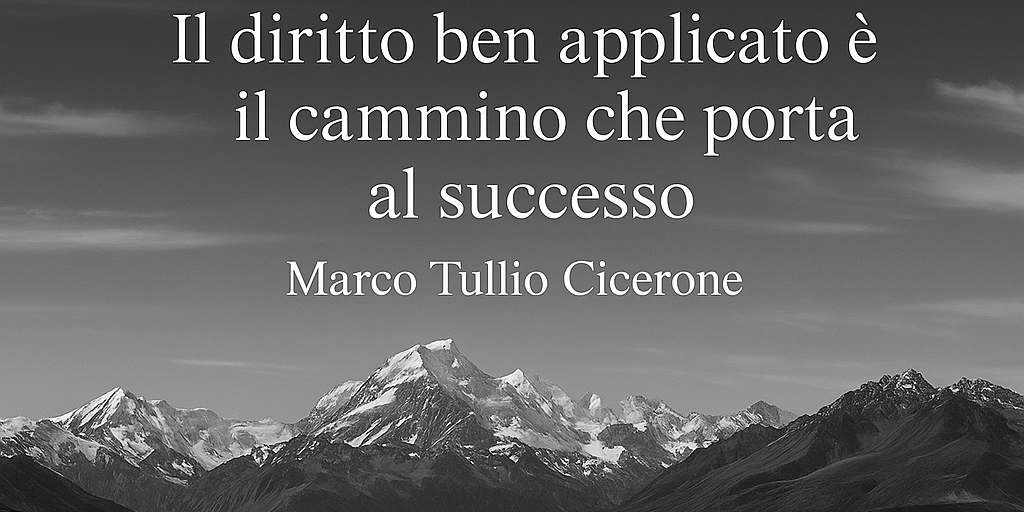L’operazione di scissione societaria rappresenta uno degli strumenti più versatili e strategici a disposizione delle imprese per attuare processi di riorganizzazione aziendale. Essa consente di separare e riallocare rami d’azienda, patrimoni immobiliari o liquidità, rispondendo a molteplici esigenze, quali la specializzazione delle attività, la preparazione al passaggio generazionale o l’ottimizzazione della gestione. Il principale vantaggio di tale operazione risiede nel suo regime di neutralità fiscale, che, tuttavia, deve essere maneggiato con estrema cautela per non incorrere in contestazioni di abuso del diritto da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
1. Inquadramento Giuridico e Fiscale della Scissione
La scissione, disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile, non è un atto di trasferimento in senso stretto, ma una modifica dell’assetto organizzativo della società. Con essa, una società (la “scissa”) assegna il suo intero patrimonio (scissione totale) o parte di esso (scissione parziale) a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione. Questo processo non realizza una circolazione di beni, ma una riorganizzazione delle risorse dell’ente, garantendo la continuità patrimoniale e dell’attività d’impresa in una nuova veste strutturale [1]. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato questo orientamento, definendo la scissione una “vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in nuovo assetto organizzativo” [2].
Il cardine della disciplina fiscale è il principio di neutralità, sancito dall’articolo 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) [3][4]. In base a tale principio:
- Nessuna Plusvalenza Imponibile: La scissione non dà luogo alla realizzazione né alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze sui beni della società scissa, inclusi l’avviamento e le rimanenze [3][4]. I beni vengono trasferiti alla società beneficiaria mantenendo il loro ultimo valore fiscalmente riconosciuto, in un regime di continuità dei valori [5][6].
- Neutralità per i Soci: Il cambio delle partecipazioni originarie con quelle delle società beneficiarie non costituisce realizzo di plusvalenze per i soci, a meno che non vengano corrisposti conguagli in denaro [3][4][7].
- Continuità delle Posizioni Fiscali: Le posizioni soggettive della scissa (ad esempio, le riserve in sospensione d’imposta) si trasferiscono alle beneficiarie in proporzione al patrimonio netto trasferito [3].
Questo regime di neutralità trova la sua radice nella normativa comunitaria, in particolare nella Direttiva 2009/133/CE, che mira a non ostacolare con oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione tra società di Stati membri diversi [8].
2. L’Utilizzo Strategico della Scissione per il Trasferimento di Liquidità e Immobili
La neutralità fiscale rende la scissione uno strumento particolarmente efficace per riorganizzare il patrimonio aziendale, specialmente per quanto riguarda gli asset immobiliari e la liquidità.
- Separazione del Patrimonio Immobiliare: È prassi comune utilizzare la scissione per scorporare il patrimonio immobiliare dall’attività operativa (industriale o commerciale) [9][10][11]. Una società può, ad esempio, trasferire i propri immobili a una nuova società beneficiaria (una “immobiliare di gestione”), per poi stipulare con essa contratti di locazione. Questa separazione può rispondere a valide ragioni economiche, come:
-
- Rendere più “leggera” e appetibile la società operativa per l’ingresso di nuovi soci o investitori, interessati unicamente al business caratteristico e non alla proprietà immobiliare [9][12].
- Specializzare la gestione del patrimonio immobiliare, massimizzandone la redditività [13][12].
- Proteggere gli asset immobiliari dai rischi legati all’attività operativa.
- Gestione della Liquidità: La scissione può essere impiegata anche per trasferire ingenti somme di liquidità a una o più società beneficiarie [14][6]. Tale operazione può essere funzionale a:
-
- Creare veicoli di investimento separati per differenti linee di business o per diversi rami familiari, in un’ottica di passaggio generazionale [15][6].
- Dotare una nuova iniziativa imprenditoriale delle risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo, separandola dalla gestione della liquidità dell’attività principale.
3. Il Confine con l’Abuso del Diritto: Quando la Scissione Diventa Elusiva
Il principale rischio associato all’utilizzo della scissione è la contestazione di abuso del diritto, disciplinato dall’articolo 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). Un’operazione è considerata abusiva quando, pur nel rispetto formale delle norme, è priva di sostanza economica e posta in essere essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito, in contrasto con la ratio delle norme tributarie.
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che, sebbene la scissione sia uno strumento lecito, il suo utilizzo può essere censurato se si inserisce in una concatenazione di atti finalizzati a un mero scopo elusivo, senza una reale giustificazione economica [16][17]. L’analisi non deve essere “atomistica” e limitata al singolo atto di scissione, ma deve considerare l’intera sequenza di operazioni precedenti e successive per valutarne la logica economica complessiva [16][17].
L’Agenzia delle Entrate, nelle sue risposte a interpelli, ha delineato con chiarezza le condizioni che possono far scattare una contestazione di abuso [18][14][19]. In particolare, una scissione è a rischio quando:
- È finalizzata a creare “società di mero godimento”: La società beneficiaria non deve essere un mero “contenitore” di beni (immobili o liquidità) privo di qualsiasi operatività, il cui unico scopo è rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti o la distribuzione di utili ai soci [18][14][19][20].
- Surroga un’assegnazione di beni ai soci: L’operazione non deve mascherare una distribuzione di patrimonio ai soci, che sarebbe un’operazione fiscalmente onerosa. L’interesse perseguito deve essere quello delle società coinvolte, non quello personale dei soci [14][6].
- È preordinata alla cessione delle partecipazioni: Se la scissione è solo il primo passo per cedere le quote della beneficiaria, sfruttando il regime fiscale più favorevole previsto per le plusvalenze finanziarie (PEX) rispetto alla cessione diretta degli asset sottostanti (es. immobili), l’operazione può essere considerata elusiva [20][12].
4. Condizioni per un Utilizzo Legittimo della Scissione
Per utilizzare la scissione in modo fiscalmente legittimo, è fondamentale che l’operazione sia supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali [5][6]. La prassi dell’Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza hanno identificato una serie di condizioni necessarie:
- Sostanza Economica e Finalità di Riorganizzazione: L’operazione deve inserirsi in un progetto concreto di riorganizzazione aziendale, finalizzato a migliorare la struttura o la funzionalità dell’impresa [5][9][10]. Le finalità devono essere documentate e dimostrabili (es. piani industriali, verbali del CdA, relazioni illustrative).
- Continuazione dell’Attività Imprenditoriale: Ciascuna società partecipante all’operazione (scissa e beneficiarie) deve proseguire un’effettiva attività d’impresa [14][19][6]. I beni trasferiti, inclusa la liquidità, devono essere impiegati in un contesto imprenditoriale (es. investimenti, sviluppo di nuovi business) e non destinati a finalità estranee all’impresa, come l’uso personale o familiare dei soci [14][6][13].
- Assenza di Vantaggi Fiscali Indebiti: Il vantaggio fiscale ottenuto (la neutralità) non deve essere “indebito”. La scelta della scissione, se posta su un piano di pari dignità con altre operazioni lecite (come l’assegnazione agevolata, quando disponibile), rientra nella legittima libertà di scelta del contribuente [21]. Tuttavia, non deve aggirare la tassazione che sarebbe derivata da un’operazione fiscalmente più onerosa ma più coerente con la sostanza economica dell’obiettivo (es. la distribuzione di utili).
In conclusione, la scissione societaria è uno strumento di pianificazione fiscale e societaria di grande valore. La sua efficacia è però subordinata a una rigorosa aderenza ai principi di sostanza economica e di finalità imprenditoriale. Un’operazione di scissione che trasferisce liquidità o immobili deve essere inquadrata in un chiaro e documentato progetto di riorganizzazione, volto a generare benefici gestionali, organizzativi o strategici per le società coinvolte, e non a soddisfare meri interessi personali dei soci o a conseguire un risparmio d’imposta come scopo principale. Una pianificazione attenta e una solida documentazione delle ragioni extrafiscali sono, pertanto, imprescindibili per difendere la legittimità dell’operazione di fronte a eventuali contestazioni.
Elimina le citazioni
La Scissione Societaria: Vantaggi Fiscali e Limiti all’Abuso del Diritto nel Trasferimento di Asset Immobiliari e Liquidità
L’operazione di scissione societaria rappresenta uno degli strumenti più versatili e strategici a disposizione delle imprese per attuare processi di riorganizzazione aziendale. Essa consente di separare e riallocare rami d’azienda, patrimoni immobiliari o liquidità, rispondendo a molteplici esigenze, quali la specializzazione delle attività, la preparazione al passaggio generazionale o l’ottimizzazione della gestione. Il principale vantaggio di tale operazione risiede nel suo regime di neutralità fiscale, che, tuttavia, deve essere maneggiato con estrema cautela per non incorrere in contestazioni di abuso del diritto da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
1. Inquadramento Giuridico e Fiscale della Scissione
La scissione, disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile, non è un atto di trasferimento in senso stretto, ma una modifica dell’assetto organizzativo della società. Con essa, una società (la “scissa”) assegna il suo intero patrimonio (scissione totale) o parte di esso (scissione parziale) a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione. Questo processo non realizza una circolazione di beni, ma una riorganizzazione delle risorse dell’ente, garantendo la continuità patrimoniale e dell’attività d’impresa in una nuova veste strutturale. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato questo orientamento, definendo la scissione una “vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in nuovo assetto organizzativo”.
Il cardine della disciplina fiscale è il principio di neutralità, sancito dall’articolo 173 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In base a tale principio:
- Nessuna Plusvalenza Imponibile: La scissione non dà luogo alla realizzazione né alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze sui beni della società scissa, inclusi l’avviamento e le rimanenze. I beni vengono trasferiti alla società beneficiaria mantenendo il loro ultimo valore fiscalmente riconosciuto, in un regime di continuità dei valori.
- Neutralità per i Soci: Il cambio delle partecipazioni originarie con quelle delle società beneficiarie non costituisce realizzo di plusvalenze per i soci, a meno che non vengano corrisposti conguagli in denaro.
- Continuità delle Posizioni Fiscali: Le posizioni soggettive della scissa (ad esempio, le riserve in sospensione d’imposta) si trasferiscono alle beneficiarie in proporzione al patrimonio netto trasferito.
Questo regime di neutralità trova la sua radice nella normativa comunitaria, in particolare nella Direttiva 2009/133/CE, che mira a non ostacolare con oneri fiscali le operazioni di riorganizzazione tra società di Stati membri diversi.
2. L’Utilizzo Strategico della Scissione per il Trasferimento di Liquidità e Immobili
La neutralità fiscale rende la scissione uno strumento particolarmente efficace per riorganizzare il patrimonio aziendale, specialmente per quanto riguarda gli asset immobiliari e la liquidità.
- Separazione del Patrimonio Immobiliare: È prassi comune utilizzare la scissione per scorporare il patrimonio immobiliare dall’attività operativa (industriale o commerciale). Una società può, ad esempio, trasferire i propri immobili a una nuova società beneficiaria (una “immobiliare di gestione”), per poi stipulare con essa contratti di locazione. Questa separazione può rispondere a valide ragioni economiche, come:
-
- Rendere più “leggera” e appetibile la società operativa per l’ingresso di nuovi soci o investitori, interessati unicamente al business caratteristico e non alla proprietà immobiliare.
- Specializzare la gestione del patrimonio immobiliare, massimizzandone la redditività.
- Proteggere gli asset immobiliari dai rischi legati all’attività operativa.
- Gestione della Liquidità: La scissione può essere impiegata anche per trasferire ingenti somme di liquidità a una o più società beneficiarie. Tale operazione può essere funzionale a:
-
- Creare veicoli di investimento separati per differenti linee di business o per diversi rami familiari, in un’ottica di passaggio generazionale.
- Dotare una nuova iniziativa imprenditoriale delle risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo, separandola dalla gestione della liquidità dell’attività principale.
3. Il Confine con l’Abuso del Diritto: Quando la Scissione Diventa Elusiva
Il principale rischio associato all’utilizzo della scissione è la contestazione di abuso del diritto, disciplinato dall’articolo 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). Un’operazione è considerata abusiva quando, pur nel rispetto formale delle norme, è priva di sostanza economica e posta in essere essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale indebito, in contrasto con la ratio delle norme tributarie.
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che, sebbene la scissione sia uno strumento lecito, il suo utilizzo può essere censurato se si inserisce in una concatenazione di atti finalizzati a un mero scopo elusivo, senza una reale giustificazione economica. L’analisi non deve essere “atomistica” e limitata al singolo atto di scissione, ma deve considerare l’intera sequenza di operazioni precedenti e successive per valutarne la logica economica complessiva.
L’Agenzia delle Entrate, nelle sue risposte a interpelli, ha delineato con chiarezza le condizioni che possono far scattare una contestazione di abuso. In particolare, una scissione è a rischio quando:
- È finalizzata a creare “società di mero godimento”: La società beneficiaria non deve essere un mero “contenitore” di beni (immobili o liquidità) privo di qualsiasi operatività, il cui unico scopo è rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti o la distribuzione di utili ai soci.
- Surroga un’assegnazione di beni ai soci: L’operazione non deve mascherare una distribuzione di patrimonio ai soci, che sarebbe un’operazione fiscalmente onerosa. L’interesse perseguito deve essere quello delle società coinvolte, non quello personale dei soci.
- È preordinata alla cessione delle partecipazioni: Se la scissione è solo il primo passo per cedere le quote della beneficiaria, sfruttando il regime fiscale più favorevole previsto per le plusvalenze finanziarie (PEX) rispetto alla cessione diretta degli asset sottostanti (es. immobili), l’operazione può essere considerata elusiva.
4. Condizioni per un Utilizzo Legittimo della Scissione
Per utilizzare la scissione in modo fiscalmente legittimo, è fondamentale che l’operazione sia supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali. La prassi dell’Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza hanno identificato una serie di condizioni necessarie:
- Sostanza Economica e Finalità di Riorganizzazione: L’operazione deve inserirsi in un progetto concreto di riorganizzazione aziendale, finalizzato a migliorare la struttura o la funzionalità dell’impresa. Le finalità devono essere documentate e dimostrabili (es. piani industriali, verbali del CdA, relazioni illustrative).
- Continuazione dell’Attività Imprenditoriale: Ciascuna società partecipante all’operazione (scissa e beneficiarie) deve proseguire un’effettiva attività d’impresa. I beni trasferiti, inclusa la liquidità, devono essere impiegati in un contesto imprenditoriale (es. investimenti, sviluppo di nuovi business) e non destinati a finalità estranee all’impresa, come l’uso personale o familiare dei soci.
- Assenza di Vantaggi Fiscali Indebiti: Il vantaggio fiscale ottenuto (la neutralità) non deve essere “indebito”. La scelta della scissione, se posta su un piano di pari dignità con altre operazioni lecite (come l’assegnazione agevolata, quando disponibile), rientra nella legittima libertà di scelta del contribuente. Tuttavia, non deve aggirare la tassazione che sarebbe derivata da un’operazione fiscalmente più onerosa ma più coerente con la sostanza economica dell’obiettivo (es. la distribuzione di utili).
In conclusione, la scissione societaria è uno strumento di pianificazione fiscale e societaria di grande valore. La sua efficacia è però subordinata a una rigorosa aderenza ai principi di sostanza economica e di finalità imprenditoriale. Un’operazione di scissione che trasferisce liquidità o immobili deve essere inquadrata in un chiaro e documentato progetto di riorganizzazione, volto a generare benefici gestionali, organizzativi o strategici per le società coinvolte, e non a soddisfare meri interessi personali dei soci o a conseguire un risparmio d’imposta come scopo principale. Una pianificazione attenta e una solida documentazione delle ragioni extrafiscali sono, pertanto, imprescindibili per difendere la legittimità dell’operazione di fronte a eventuali contestazioni.
Avv. Paolo Borrelli
Fonti citate
- Corte di Appello di Palermo, Sentenza n.102 del 17 gennaio 2024 (2024)
- Cass. Civ., Sez. 5, N. 28169 del 27-09-2022 (2022)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 (1986)
- DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344 (2003)
- Risposta n. 282 del 23/04/2021 (2021)
- Risposta n. 263 del 21/03/2023 (2023)
- Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Como, sentenza n. 68/2024 (2024)
- Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (versione codificata) (2009)
- Parere n. 50 del 15/12/2005 (2005)
- Parere n. 9 del 25/03/2004 (2004)
- Parere n. 24 del 25/07/2006 (2006)
- Parere n. 12 del 22/03/2007 (2007)
- Risposta n. 233 del 1/03/2023 (2023)
- Risposta n. 35 del 8/02/2024 (2024)
- Risposta n. 537 del 24/12/2019 (2019)
- Cass. Civ., Sez. 5, N. 27870 del 29-10-2024 (2024)
- Cass. Civ., Sez. 5, N. 27905 del 29-10-2024 (2024)
- Risposta n. 354 del 20/06/2023 (2023)
- Risposta n. 503 del 12/10/2022 (2022)
- Risoluzione n. 56 del 22/03/2007 (2007)
- Risposta n. 75 del 22/11/2018 (2018)